 immagine via Shane Anderson
immagine via Shane Anderson
Michele Sisto
Nella sua autobiografia recentemente tradotta in italiano (Guerra senza battaglia, Zandonai) Heiner Müller racconta di un viaggio in taxi, a Berlino Est nel 1959, insieme allo scrittore antifascista Ludwig Renn e Hans Henny Jahnn, allora sessantacinquenne. «Naturalmente mi interessava soprattutto Hans Henny Jahnn», precisa. Dall’incontro non ricava molto, se non, dopo essersi acceso una sigaretta, una reprimenda a due voci su quanto il fumo faccia male alla salute. Ma dietro la consueta, beffarda impassibilità con cui l’aneddoto viene riferito, traspare l’eccitazione del giovane scrittore, appena premiato per lo Stakanovista, che ha l’occasione di conoscere un maestro.
Jahnn: «Uno dei maestri segreti della prosa del Novecento» lo definisce sul risvolto di copertina Domenico Pinto, che cura l’edizione di queste 13 storie inospitali (nonché la coraggiosa collana ‘Arno’ che le ospita per i tipi di Lavieri). Jahnn l’espressionista: che nel 1923 aveva esordito col crudo dramma Pastor Ephraim Magnus, messo in scena dal giovane regista Bertolt Brecht. Jahnn il modernista: che con il romanzo fiume Perrudja, pubblicato nel 1929, era stato tra i primi a proseguire la rivoluzione joyciana in lingua tedesca, suscitando l’entusiasmo di Alfred Döblin. Jahnn l’inclassificabile: che nelle duemila pagine della trilogia Fluß ohne Ufer (Fiume senza rive), uscita nel 1949-50, si propone nientemeno che di inaugurare un nuovo principio di rappresentazione romanzesca, costruendo i personaggi non sulla base di un «carattere», la cui coerenza considera del tutto fittizia, ma come contraddittoria manifestazione di una natura innanzitutto corporea, come «risultato di un’attività secretiva». Hans Henny Jahnn (al secolo Hans Henry Jahn), dove Henny è il diminutivo Henriette: che è noto e apprezzato solo da una ristretta cerchia di scrittori e per il resto gode di pessima fama («Non assomiglio per niente a quel che si dice di me», scrive nel ’32). Ed è proprio per questo che Müller fa le viste di preferirlo – «naturalmente» – all’(allora) assai più celebre quanto convenzionale Ludwig Renn. Jahnn è uno scrittore scandaloso.
Ma da dove viene questo monstrum, che ha così profondamente influenzato la letteratura tedesca dell’ultimo secolo – fino a Peter Weiss, Rolf Dieter Brinkmann, Botho Strauß – pur rimanendone inesorabilmente ai margini? Il clima culturale in cui si forma è quello dell’irrazionalismo primonovecentesco, tra l’eredità di Nietzsche e le Lebensphilosophien: nato nel 1894, educato secondo i rigori borghesi della Germania guglielmina, sfugge alla carneficina della Grande guerra, nella quale viene decimata la prima generazione dell’espressionismo, riparando in Norvegia. Al suo rientro ad Amburgo la Germania è un brulicare di correnti di pensiero e artistiche che oppongono alla modernizzazione, percepita come inesorabilmente snaturante e distruttiva, la restaurazione di un passato pre-capitalistico, o di un altrove, variamente idealizzati: il medioevo germanico, la saggezza dell’oriente, l’ortodossia cattolica (o d’altro credo), l’antica Grecia, l’antica Roma, l’antico Egitto, la preistoria, e via dicendo. Anche Jahnn prende parte a questa affannosa fuga dalla Zivilisation, non solo avvicinandosi agli espressionisti ma progettando nei primi anni ’20 una comunità di artisti che avrebbe dovuto vivere in campagna, secondo rituali propri, realizzando costruzioni e opere d’arte ispirate una creatività liberata e pacifica. Di questo progetto non rimane che la casa editrice Ugrino, con la quale Jahnn, che di mestiere è costruttore d’organi, pubblica partiture di Buxtehude e altri compositori barocchi. Le sue posizioni di questi anni, fino alle battaglie del dopoguerra contro le armi atomiche e gli esperimenti sugli animali, sono ampiamente testimoniate nelle 2569 pagine dei suoi scritti su arte, letteratura e politica, pubblicati nel 1991, ma ne troviamo una sintesi nelle parole del garzone del latte Egil Berg, protagonista dell’ottava storia “inospitale”, I mangiatori di marmellata, scritta nel 1928:
Gli europei di buona volontà devono opporsi ai metodi dell’Europa. Devono imparare a odiare ciò che li martirizza. La fede cieca nei benefici dell’ingegneria e della scienza deve crollare. Siamo devastati perché disgiunti dalle energie della terra che ci sostiene. Saremo logorati dal rumore e dalle folle incalzanti. Siamo imprigionati in una rete: il nostro cibo e le nostre abitazioni innaturali. La maggior parte degli uomini del nostro continente non potrà trovare salvezza davanti al tribunale venturo.
Si approssima la grande crisi del ’29, il declino della repubblica di Weimar, l’ascesa al potere di Hitler. Che fare? Mentre Brecht si avvicina alla politica (al comunismo) e Döblin alla religione (al cattolicesimo), i due farmaci – forse omeopatici – con cui storicamente si è fronteggiata la gorgone della modernizzazione capitalistica, Jahnn tenta invece di azzerare ogni sovrastruttura, mettendo come tra parentesi la civiltà e ripartendo dalla nuda vita, dal nudo corpo, visto quasi come un aggregato di cellule. Siamo dalle parti di Gottfried Benn e dei suoi Canti: «Oh se fossimo i nostri avi primevi, / un grumo di muco in una palude calda. / Vita e morte, fecondazione e parto / verrebbero dai nostri muti umori». E dunque non siamo lontani da quell’anticapitalismo romantico che, secondo Lukács, avrebbe nutrito il nazionalsocialismo, o quantomeno si sarebbe rivelato ideologicamente compatibile con esso. Anche Jahnn, sebbene bollato dai nazisti come «pornografo e comunista» ed emigrato in Danimarca già nel ’34, rimane iscritto alla Camera degli scrittori del Reich e continua a pubblicare e viaggiare in Germania per tutto il dodicennio hitleriano.
Il desiderio di un mutamento radicale e, al tempo stesso, l’assenza di prospettiva politica concreta sono incisi nell’impianto delle opere maggiori, al limite della farneticazione. L’antieroico ‘riformatore del mondo’ Perrudja, ultramiliardario e dalla sessualità incerta, dopo aver tentato la comune e poi il matrimonio (non senza prima aver ucciso il promesso sposo della moglie) progetta una guerra con le più moderne armi di annientamento per costringere i governi a instaurare finalmente la giustizia e la pace. Né è meno inquietante la storia di Gustav Anias Horn, protagonista di Fluß ohne Ufer, che sopravvive all’affondamento di una misteriosa ‘nave di legno’ sulla quale è stata uccisa la sua fidanzata e, divenuto anch’egli inopinatamente ricchissimo, gira il mondo insieme all’assassino di lei, il marinaio Alfred Tutein, amandolo al punto da imbalsamarlo una volta morto e conservarne il corpo in una cassapanca.
Le 13 storie inospitali, resecate dal continuum dei due romanzi e assemblate nel 1954 in questa autoantologia, sono, più che un distillato, un assaggio dei temi e della scrittura di Jahnn. A tutta prima, leggendole, e ancor più leggendo La nave di legno, primo tomo di Fluß ohne Ufer tradotto da Rizzoli nel 1966, si sarebbe tentati di lasciare Jahnn all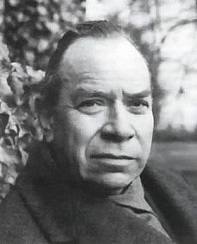 a polvere delle biblioteche, o ai répechage a cui ci ha abituati – nel male e nel bene – la Biblioteca Adelphi. Eppure è difficile non avvertire il fascino, o meglio il potenziale di verità che alligna tra le pagine di questa prosa abnorme. «Indubbiamente Jahnn è uno scrittore notevole, ma tra genio e pazzia la seconda prevale», scriveva Cesare Cases in un parere di lettura, per Einaudi, nel 1958. Né poteva essere altra l’impressione di chi era convinto che la modernizzazione fosse governabile con gli strumenti razionali e collettivi del socialismo. Ma ora che quegli strumenti hanno mostrato la loro inefficacia – quantomeno nel loro utilizzo novecentesco – è possibile rileggere Jahnn meno preoccupati delle sue ambiguità politico-ideologiche e più disponibili nei confronti della sua indagine “antropologica”.
a polvere delle biblioteche, o ai répechage a cui ci ha abituati – nel male e nel bene – la Biblioteca Adelphi. Eppure è difficile non avvertire il fascino, o meglio il potenziale di verità che alligna tra le pagine di questa prosa abnorme. «Indubbiamente Jahnn è uno scrittore notevole, ma tra genio e pazzia la seconda prevale», scriveva Cesare Cases in un parere di lettura, per Einaudi, nel 1958. Né poteva essere altra l’impressione di chi era convinto che la modernizzazione fosse governabile con gli strumenti razionali e collettivi del socialismo. Ma ora che quegli strumenti hanno mostrato la loro inefficacia – quantomeno nel loro utilizzo novecentesco – è possibile rileggere Jahnn meno preoccupati delle sue ambiguità politico-ideologiche e più disponibili nei confronti della sua indagine “antropologica”.
È su questo terreno infatti che va misurata la sua scrittura, lo stesso sul quale da noi si sono mossi (beninteso: con risultati diversissimi) autori altrettanto recalcitranti a farsi arruolare nelle opposte schiere del progresso e della reazione: il Leopardi dispregiatore delle “magnifiche sorti e progressive” e il Pasolini studioso della “rivoluzione antropologica”. Se all’autore di Canti e delle Operette morali lo avvicina la tendenza a scarnificare la storia fino a ridurla ai tratti essenziali, spesso mitici, dell’infelicità costituiva dell’essere umano e delle sue pulsioni primarie, col secondo Jahnn condivide l’indagine sul corpo, sui sensi, sul sesso come strumento di verità, anche sociale (penso alle Lettere luterane, e soprattutto a Salò). Per molti aspetti Jahnn, tuttavia, si spinge oltre, e, perseguendo nel solco dell’Ecce homo di Nietzsche una sorta di fisiologia unificata del corpo e dello spirito, dell’animale umano indaga gli impulsi più oscuri: la generazione, la morte, la brama di piacere, la sopraffazione, la dedizione autolesionista, tutto ciò che, se non represso, farebbe saltare le convenzioni su cui si fonda il vivere civile. Jahnn solleva il coperchio dei tabù, che come è noto sono sempre in prima istanza sessuali, e rimesta nella pentola delle pulsioni che la morale tiene a bada imponendo divieti: incesto, adulterio, omosessualità, zoofilia, necrofilia, cannibalismo.
La sua scrittura tende a cancellare ogni distinzione tra bene e male, ma anche tra amore e odio, creazione e distruzione, realtà e fantasia, ricostituendo il magma contraddittorio e vitale dell’esistenza: ciò che la civiltà ha distinto, segregato, torna all’unità, all’indistinto. In Jahnn gli esseri umani si annusano come bestie, per riconoscere la rispettiva energia vitale, o la sua assenza: è tutto un lussureggiare di sangue, sudore, seme, di ossa, muscoli e afrori, «la danza della vita all’ombra della morte». Solo attraverso rituali, spesso assurdi e dunque immediatamente smascherati come tali, il nudo, ingovernabile materiale umano si dà provvisoriamente un ordine, un senso: rituali di preparazione alla morte (Kebad Kenya), di assoggettamento a un padrone (La storia dello schiavo, Un signore sceglie il suo servo), di dedizione amorosa (Ragna e Nils, Il tuffatore).
È come se gli esseri umani, in Jahnn, non fossero altro che la sede temporanea di un’energia che li trascende e che è destinata a fluire altrove: l’individuo, concetto cardine della civiltà occidentale, cessa di essere l’agente per diventare il luogo dell’azione (der Schauplatz der Ereignisse). «Le cose di questo mondo hanno un destino. Il loro destino è: estinguersi, consumarsi nella loro forma per divenire materia di una nuova forma».
Nel racconto Il re sassanide, ad esempio, questa energia, che si era manifestata con enorme intensità nel re di Persia Cosroe II, «insaziabile di felicità», facendogli conquistare popoli, terre, tesori e piaceri infiniti, a un certo momento – segnalato dalla morte della sua giumenta Shabdez (il cavallo in Jahnn è sempre simbolo dell’energia vitale) – migra altrove: forse nella carne e nel sangue dello scultore incaricato di erigere un monumento all’animale, Fahrad, il quale dà prova di una passione artistica così profonda da suscitare l’amore di Shirin, la concubina di Cosroe, e da innescare la distruttiva quanto vana vendetta di questi, ormai destinato alla morte, e la sua famiglia a estinguersi in una scia di assassinii. La tesi è esplicita:
Noi, uomini folli [moderni], sosteniamo con ostinazione che, fra i grandi princìpi, siano la battaglia, la vittoria e la sconfitta a muovere i nostri cuori e a indurli a prendere delle decisioni. Menzogne. Senza la carne viva del singolo l’astrazione più audace e spirituale è lo scheletro di un morto. Vi è più senno nei bagordi di un figlio della terra che nella pia carità di una donna provata e senza più il coraggio di un desiderio pur che sia.
Jahnn si richiama espressamente all’umanesimo leonardesco affermando che «lo spirito separato dai sensi non può che produrre verità distruttive». E su questo costruisce la sua visione del mondo e, soprattutto, il suo stile. Stile arduo, che la traduzione di Elisa Perotti restituisce coraggiosamente in italiano con esiti che di pagina in pagina si fanno più persuasivi. Ciascuna frase tende, con ogni possibile strategia, a tradurre l’astratto in concreto, la parola in esperienza per tutti e cinque i sensi. Jahnn indugia sulle percezioni, le chiosa, non si fa scrupolo di spezzare il flusso della narrazione, di frammentarlo, per insistere su un dettaglio, o cambiare visuale cedendo la parola a un personaggio attraverso il monologo interiore, o perfino intervenire in prima persona. Questa la torsione espressiva che viene data, ad esempio, agli eventi – storici – che alla fine del VI secolo portarono Cosroe II al trono di Persia:
….Bahram Chobin, l’ultimo grande della dinastia Mihran, aveva portato l’impero sassanide vicino all’annientamento. Fuori di senno per il potere. Dominare, sopprimere, annegare nel sangue. Il padre di Cosroe, Ormisda, fu accecato e poi trafitto da zagaglie, ed egli, il figlio, il giovane Re dei Re, dovette fuggire a Bisanzio dall’imperatore Maurizio. Ma la buona sorte di Bahram ebbe fine. Fu eliminato con un semplice assassinio. Ferro e carne.
….Maurizio, imperatore dei bizantini, pose Cosroe, il giovane, che aveva viaggiato attraverso l’Asia Minore.
….Suo padre trafitto da zagaglie. Ferro e carne.
….Hai tremato. Hai avuto paura. Hai pianto. Andasti a cavallo. Le cosce ferite. Sulle strade pietrose. Anche le mani erano andate alla ricerca.
….Lo designò sovrano.
Se il nordico Thomas Mann, col suo tentativo di salvaguardare l’eredità della cultura borghese rivelando quanto fosse sottile e fragile la superficie della civiltà, è lo scrittore del Geist, nonché il volto composto dell’età di Weimar, l’altrettanto nordico Jahnn rappresenta il rovescio della medaglia, perché manda in pezzi quella superficie e si immerge nei Sinne fino a perdere del tutto di vista gli orizzonti valoriali della borghesia, e dunque del suo tempo: Perrudja potrebbe essere letto come controcanto alla Montagna incantata, come l’opera di un Mann che, anziché dominarle, avesse scelto di esplorare fino in fondo le oscure tentazioni del sangue velsungo, proseguendo per la ripida china delle Considerazioni di un impolitico.
Non siamo, tuttavia, di fronte all’utopia regressiva di un reazionario. C’è qualcosa che rende impossibile assimilare Jahnn al disumano nichilismo di un Benn o di uno Jünger. Qualcosa che Heiner Müller aveva colto e che in più di un’occasione ha richiamato citando una frase di Jahnn, da questi incisa nel ’34 sulla tomba dell’amato Gottlieb Harms, e nel dopoguerra posta in epigrafe al dramma Armut, Reichtum, Mensch und Tier (Povertà, ricchezza, uomo e bestia): «ALLMÄHLICH IST DIE LIEBE UNSER EIGENTUM GEWORDEN». Che suona, grossomodo, «a poco a poco l’amore è diventato nostra proprietà», ovvero: passo dopo passo ce ne siamo impadroniti, l’abbiamo conquistato. In fondo, il tema centrale di Jahnn, per quanto alle nostre orecchie postmoderne possa suonare imbarazzante, è l’amore: la sua pretesa totalizzante, la sua tragedia (c’è un che di adolescenziale in questo, come del resto in Leopardi). Di qui la sensazione, allo stesso tempo, di familiarità ed estraneità che suscita nel lettore una scrittura che, come osserva Andrea Raos nella postfazione, «è forza d’amore, estranea».
Scrive Jahnn nel ’48 in Mein Werden und mein Werk (Il mio divenire e la mia opera):
Le funzioni della vita, le cause prime, mi sono divenute assai più chiare nel corso degli ultimi tre lustri. Ho gestito un podere, ho allevato cavalli, le persone che frequentavo non erano intellettuali ma contadini. Nella stalla delle vacche, nelle stanze dei braccianti, nei campi ho conosciuto più da vicino la vita concreta. Ho superato i miei ultimi pregiudizi […] e mi sono convinto che ogni essere vivente è circonfuso dalla sacralità della sua innata costituzione, e che nessuna delle sue manifestazioni – nemmeno quelle aberranti – è innaturale, riprovevole. Credo di vedere che questa mia convinzione, per quanto ad alcuni possa apparire molesta e ripugnante, ha un obiettivo – un obiettivo ancora lontano di fronte a noi. Io credo alla possibilità dell’allargamento dell’anima umana.
A riconoscere il potenziale rivoluzionario di questa prospettiva – in cui l’amore coincide grossomodo con quell’energia vitale di cui si diceva e si estende a tutte le creature, dagli uomini d’ogni razza agli animali alle piante – è non solo Heiner Müller, ma anche il curatore dell’edizione tedesco-orientale delle 13 storie inospitali (Reclam, 1987), Klaus Schuhmann. Tutt’altro che inavvertito della tragica ambivalenza dell’amore in Jahnn, nonché dei suoi possibili risvolti antiegualitari, Schuhmann ne dà una declinazione socialista scegliendo la citazione giusta (dal Pastor Ephraim Magnus): «Solo gli animali non hanno ancora incominciato a [lasciarsi condizionare da ambizioni sbagliate]; non vogliono diventare re o ministri, ottenere medaglie o abitare palazzi; né ancora credono di essere nati sul gradino più basso di una scala». Inteso come potenza in grado di infrangere le distinzioni di classe e le gerarchie sociali l’amore di Jahnn viene ad assomigliare all’eros che negli anni ’50 Marcuse contrapponeva alla civiltà; con la differenza, tuttavia, che in Jahnn esso non si carica di valenze utopiche (o lo fa solo nella misura in cui può darsi un’utopia senza pars construens). Allo scrittore non interessa costruire un ordinamento sociale migliore bensì, come si è visto, «allargare l’anima umana», consapevole che il nudo essere, ad avere il coraggio di osservarlo, consiste nel «divorare ed essere divorati»; che la vita «è come è, ed è terribile»; che l’essere umano «è capace di tutto».
Jahnn si muove fuori dalla Storia, mostra il magma informe su cui è costruita la civiltà, di cui siamo impastati. Riesce a far riemergere ciò che la modernizzazione capitalistica (il mondo delle macchine) e la civiltà contemporanea (la riduzione delle potenzialità umane alla ragione strumentale) hanno rimosso. La sua scrittura può funzionare, ancora oggi, come antidoto all’alienazione. Nel darle corpo, annota,
mi sono attenuto all’idea di una legge, alle sue rovine, a un residuo che io chiamo la mia vita privata, la mia privata tenerezza, la mia privata indolenza, la mia privata disperazione, il mio privato fiume senza rive.
Le sue storie sono dunque programmaticamente inospitali: in tedesco nicht geheuer. Mettono a disagio, scomode, inquietanti (e poi il numero: 13). Ungeheuer ist viel. Doch nichts / ungeheuerer, als der Mensch, recita il coro dell’Antigone di Sofocle tradotto da Hölderlin (II atto): «Tra quante cose esistono terribili / nessuna è più terribile dell’uomo». Perché, per Jahnn, nicht geheuer è la natura stessa di quella «svista della creazione» che è l’essere umano: un fiume senza rive.
Michele Sisto
Hans Henny Jahnn, 13 storie inospitali, a cura di Domenico Pinto, traduzione di Elisa Perotti, postfazione di Andrea Raos, con un saggio di Ferruccio Masini, S. Angelo in Formis, Lavieri, 2010, ‘Collana Arno, 11’, 190 p.
[questa recensione è uscita, in forma abbreviata, sul numero di luglio-agosto di Galatea]


 integralmente on line!
integralmente on line!
Pingback: Foto di gruppo con scrittore – Nazione Indiana